
Il circolo dei lettori della Dozza in Salaborsa
Gruppo di lettura degli studenti e delle studentesse di Filologia Classica e Italianistica che si incontrano con i detenuti della Casa Circondariale Dozza.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato
Art. 27 della Costituzione italiana
Nato come percorso di formazione per i detenuti iscritti all'Università, il Circolo di lettura della Dozza è il gruppo di lettura degli studenti e dei docenti del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell'Università di Bologna con i detenuti della Casa Circondariale Dozza.
Da questo circolo si è sviluppato un gruppo di lettura esterno e parallello, il Circolo dei lettori della Dozza, al quale partecipano anche quei lettori che, entrando nella Casa circondariale Dozza, possono discutere dei libri con i detenuti. L'iniziativa ha l'intento di creare un ponte tra i due circoli e avvicinare altri studenti universitari e cittadini alla realtà carceraria. Il Circolo dei lettori della Dozza si riunisce, ogni quarto lunedì del mese, nella Sala conferenze di Salaborsa alle 18.
Gli incontri, coordinati dagli studenti universitari, vedono il coinvolgimento in carcere di autori e curatori delle opere.
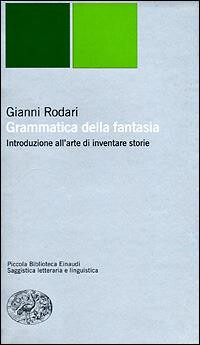
- Violazione par Alessandra Sarchi
- Il ritorno è lontano par Alessandra Sarchi
- Piccola città par Vanessa Roghi
- Paradiso par Stefano Dal Bianco
- L'ascaro: una storia anticoloniale, romanzo par Ghebreyesus Hailu
- Nuovi misteri d'Italia par Carlo Lucarelli
- Dove non mi hai portata par Maria Grazia Calandrone
- Storie naturali par Primo Levi
- Il custode delle parole par Gioacchino Criaco
- Il mio Enea par Giorgio Caproni
- Le Piccole Persone. In difesa degli animali e altri scritti par Anna Maria Ortese
- Presentazione del programma di letture
- Cetti Curfino par Massimo Maugeri
- Osa sapere. Contro la paura dell'ignoranza par Ivano Dionigi
- Un morto ogni tanto par Paolo Borrometi
- Di chi è questo cuore par Mauro Covacich


